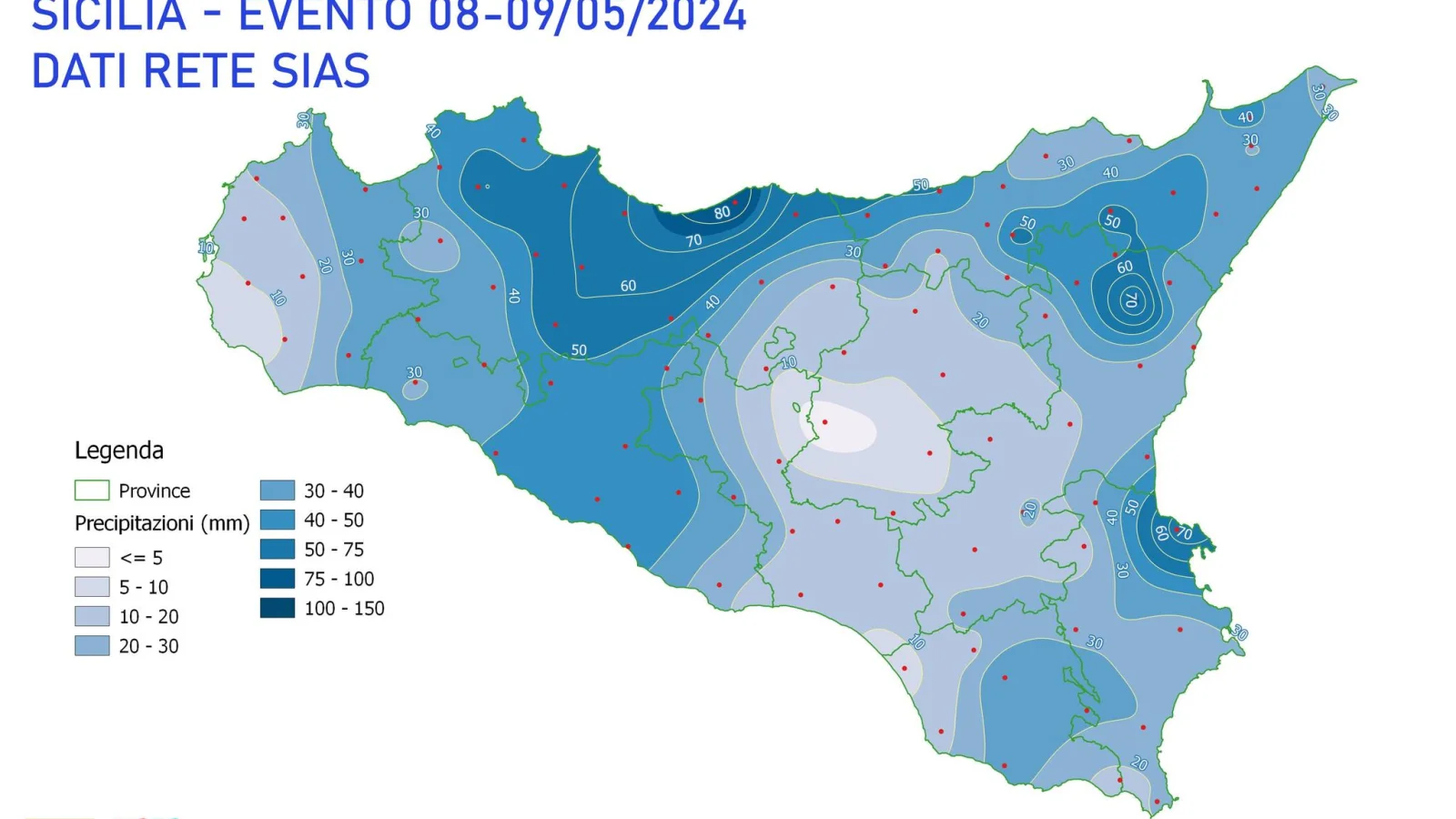Lo strano caso della Sicilia, l’isola in perenne siccità dove non manca l’acqua ma mancano le infrastrutture dell’acqua – Di Erasmo D’Angelis e Mauro Grassi
Come ne «Il gioco degli specchi», l’intrigante racconto di Andrea Camilleri, anche per la siccità in Sicilia, qualcuno vuole confondere qualcosa con riflessi ingannevoli e mezze verità. Realtà e illusione, non solo in Sicilia, in tema di acqua spesso si sfiorano e si confondono. Come anche nelle storie narrate da Leonardo Sciascia, e nel suo prezioso documento-commento al film-reportage in bianco e nero realizzato nel 1968 dal titolo provocatorio: «La grande sete in Sicilia finirà nel 2015».
Sono 34 minuti di storia siciliana e italiana attraverso l’acqua e tra pozzi, dighe, acquedotti, dissalatori e reti che facevano emerge «le mani sull’acqua», un sistema affaristico in equilibrio tra politica e criminalità, che metteva in conto omicidi come quello del giornalista Mario Francese, ammazzato nel 1979 dopo articoli di denuncia sugli strani affari intorno alle dighe. Anche il business idrico contribuì ad accrescere la potenza dei Liggio, dei Riina e dei Provenzano. Anche attraverso l’acqua ipotecavano lo sviluppo dell’isola, lasciandola ai margini dell’efficienza.
Ma la Sicilia era l’isola dell’acqua. Basterebbe ricordare quando c’era una volta la Conca d’Oro, la più bella pianura costiera tra i Monti palermitani e il mar Tirreno, il colpo d’occhio che abbagliava viaggiatori e scrittori come Johann Wolfgang Goethe che, giunto a Palermo nel 1787, incantato scrisse: «L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello spirito. Qui è la chiave di ogni cosa». Palermo poi era spettacolare per le sue acque. Ai due lati vedeva scorrere due fiumi navigabili. Uno era il Kemonia, che gli arabi chiamavano «fiume del Maltempo» perché dilagava con le piogge, ormai del tutto interrato sotto la città. L’altro, il Papireto, era il «fiume d’Occidente», alimentato da copiose sorgenti montane, e tutt’intorno la stupenda vegetazione di papiri, oggi relegato a fogna a cielo aperto e sotterrato anche lui dal periodo borbonico.
L’Isola fu la prima area italiana ad essere colonizzata. Dai Sicani, l’antico popolo che la chiamò Sicania, poi da Cretesi, Elimi, Greci, Fenici, Punici, quindi Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Francesi e Spagnoli. Palermo immagazzinava abbondanti volumi d’acqua di pioggia sotto le sue falde freatiche, con l’aggiunta di apporti idrici dalle montagne che la circondano delimitate dai fiumi Eleuterio e Jato. L’acqua non mancava mai, prelevata da pozzi e poi distribuita dai complessi e sorprendenti sistemi cunicolari che sottoattraversano la città di stampo mediorientale delle qanat. Eruditi e viaggiatori medievali ci hanno lasciato descrizioni estasiate di fonti, sorgenti, piscine, fontane, peschiere e polle zampillanti che abbondavano dentro e fuori la cerchia delle mura. Il mercante di Baghdad Ibn Hawqal, nel 943, colpito da tanta acqua, scrisse: «… gli abitanti della città vecchia al pari di quelli della Halisah (la cittadella fortificata sede dell’emiro, ndr) e del rimanente dei quartieri, dissetansi con l’acqua dei pozzi delle proprie case… e le acque abbondanti che scaturiscono intorno a Palermo e scorrono da ponente a levante con forza da volgere ciascuna due macine». Il viaggiatore arabo-andaluso Ibn-Ubayr che la visitò nel 1185 in pieno periodo normanno, racconta di giardini, torri di guardia e canali sull’agro palermitano, dimore regali immerse in rigogliosi giardini paradiso che coloravano la città e che re Ruggero definiva «sollazzi», e grandi fontane dalle quali zampillava acqua. Descrizioni che oggi sembrano inventate, ma era tutto vero. Il Parco del castello della Zisa da mille e una notte era circondato da viali, canali d’acqua e bacini collegati con reti di tubazioni di terracotta, i catusi, con acqua corrente a pressione o a caduta. E la pianura agricola era attraversata dalle canalizzazioni irrigue reticolari di superficie chiamate saje.